La caduta della Casa Usher
Son coeur est un luth suspendu;
Sitôt qu’on le touche il résonne.
Il suo cuore è un liuto sospeso;
Appena qualcuno lo tocca, suona.
DE BÉRANGER
In una giornata triste, buia e troppo silenziosa, con un cielo di nuvole basse e pesanti, dopo aver cavalcato da solo per un tratto di campagna particolarmente desolato, verso sera, mentre le ombre si facevano sempre più lunghe, mi trovai di fronte alla malinconica casa Usher.
Non so perché, bastò uno sguardo di sfuggita alla vecchia dimora, per darmi un senso di insopportabile depressione; insopportabile, perché questa mia sensazione non era addolcita dal fascino, quasi perverso, che hanno, perché poetiche, anche le più crude immagini di desolazione e terrore.
Guardavo la scena che si presentava ai miei occhi, guardavo quella casa e le nude strutture della proprietà, le mura lugubri segnate dagli sguardi vuoti delle finestre, i sedili, i tronchi bianchi degli alberi morti. Guardavo, con quell’oppressione totale dell’anima, paragonabile soltanto al risveglio dai piaceri dell’oppio, verso l’amaro intervallo della normalità quotidiana: il tragico cadere del velo. Era agghiacciante da far mancare il cuore, si era assaliti da un’irrimediabile tristezza che nessuno stimolo dell’immaginazione avrebbe più potuto sublimare. Mi chiedevo cosa fosse, cosa, in questa contemplazione della casa Usher mi indebolisse tanto. Era un insolubile mistero; né potevo combattere le fantasie che in questa riflessione, riempivano la mia testa. Ero costretto a limitarmi a una conclusione abbastanza insoddisfacente, cioè, che certamente esistono combinazioni di oggetti semplicissimi, naturali fino alla banalità, che hanno il potere di impressionarci, ma che, nello stesso tempo, tale potere resta per noi non analizzabile, superiore al potere della nostra mente.
Riflettei che un semplice cambiamento nei particolari della scena, negli elementi del quadro, sarebbe stato sufficiente a modificare o, forse annientare, l’incredibile forza di questa impressione tanto penosa; seguendo questa idea spinsi il cavallo fino al bordo scosceso di uno stagno nero e sinistro, che specchiava immobile la costruzione.
Guardai in basso nelle sue acque e vedendovi le immagini capovolte e deformate dei sedili grigi, dei tronchi incolori e di quelle finestre simili a occhi vuoti, provai un brivido ancora più forte.
Nonostante la sua aria tenebrosa, mi proponevo di soggiornare alcune settimane proprio lì, in quella dimora spettrale. Roderick Usher era stato un mio compagno di baldorie del tempo della giovinezza, anche se troppi anni erano passati dal nostro ultimo incontro; recentemente, una lettera mi aveva raggiunto in un luogo remoto del paese, una sua lettera talmente insistente che non mi aveva lasciato altra possibilità che quella di raggiungerlo immediatamente.
Il manoscritto esprimeva uno stato di acuta tensione nervosa. Lo scrivente parlava di un suo stato di grave malattia, di una confusione mentale che lo opprimeva. Voleva vedermi a tutti i costi; ero il suo unico intimo amico e sperava di trovare nella mia allegra compagnia un sollievo al male. Il modo estremamente sincero con cui tutto ciò veniva detto, e altro ancora, non lasciavano spazio per decisioni diverse, e malgrado fossi convinto che si trattava di un invito assai strano, accettai.
Sebbene la nostra amicizia da ragazzi fosse molto intensa, in realtà sapevo molto poco del mio amico. Il suo costante riserbo mi era sempre parso eccessivo.
Sapevo che la sua antichissima famiglia si era distinta, da tempo immemorabile, per una sua particolare sensibilità, rivelatasi attraverso secoli, in molte opere artistiche di rilievo, e, manifestatasi ultimamente, in azioni caritatevoli e generose, come pure in una intensa devozione per i misteri, più che per le ortodosse e banalmente riconoscibili bellezze della scienza musicale. Ero anche al corrente del fatto, veramente sorprendente, che la famiglia degli Usher, nonostante la sua celebrata storia, non aveva mai dato origine a rami collaterali durevoli. In altre parole, l’intera famiglia era in linea di discendenza diretta e, tranne qualche insignificante e transitoria variazione, era sempre stato così.
Era stata questa carenza – pensai, mentre riflettevo sulle mie impressioni sul paesaggio e le mettevo a confronto con questo carattere della famiglia, ragionando sulla possibile influenza nel corso dei secoli dell’uno sull’altro -, forse proprio questa mancanza di un ramo cadetto e la conseguente trasmissione diretta di patrimonio e nome, di padre in figlio, che alla lunga li aveva identificati, fino al punto di fondere il primitivo nome del possedimento nella singolare e ambigua denominazione di «Casa Usher»; un nome il quale, nella mente della gente del contado che lo usava, definiva tanto la famiglia quanto la sua dimora.
Ho detto che l’unico effetto del mio esperimento, per la verità un po’ infantile, cioè di guardare nello stagno, era stato di render ancor più profonda la mia prima impressione di anomalia. Non c’è dubbio che accorgermi di essere ormai preda della superstizione, inutile chiamarla in altro modo, contribuì a moltiplicare e accelerare il processo. Come so da molto tempo, questa è la legge paradossale di tutti gli stati d’animo che hanno origine dal terrore; e forse per questa sola ragione, mentre tornavo a guardare direttamente la casa, dopo averne contemplato l’immagine nello stagno, sentivo crescere nella mente una nuova fantasia, un’illusione talmente ridicola, che poteva essere giustificata soltanto dalla potenza delle sensazioni che mi angustiavano.
La mia immaginazione si era scatenata al punto da essere veramente sicuro che tutta la proprietà, dalla casa al paesaggio circostante, fosse gravata da un’atmosfera creata da loro, dal loro mondo cupo, un’aria che aveva abolito il celeste, che trasudava dai tronchi morti, dai muri grigi, dallo stagno silenzioso: una nebbia nociva e mefitica, misteriosa e opprimente; quasi impercettibile e tinta di piombo.
Mi liberai da questa impressione che per forza doveva essere un brutto sogno per osservare, con più attenzione, l’aspetto della casa. Il suo connotato più evidente sembrava essere la sua eccessiva antichità. I secoli le avevano conferito una perdita di colore inquietante. Sull’intera facciata si estendeva un fittissimo tessuto di spore. Ma tutto questo era lungi dall’associarsi a segni di decadenza. In nessuna parte c’erano tracce di crollo dei muri: con il risultato di una strana incoerenza fra questa perfetta tenuta dell’insieme e la condizione di fatiscenza delle singole pietre.
Tutto questo mi faceva venire in mente quelle strutture lignee apparentemente intatte che sono rimaste per tanto tempo al riparo dell’aria in una cantina qualsiasi, sopravvissute all’usura dei lunghi anni trascorsi.
Ma, a parte questa notazione di uno stato di grave degrado, la struttura dell’edificio non dava un’idea di instabilità. Forse solo lo sguardo di un osservatore meticoloso avrebbe potuto accorgersi di una esilissima incrinatura che, partendo dal tetto, scendeva trasversalmente lungo la facciata, per perdersi nelle lugubri acque dello stagno.
Immerso in queste notazioni, avevo percorso un breve ponte che portava alla casa. Mi aspettava un servo che prese in consegna il mio cavallo, e io potei finalmente entrare. Fui introdotto sotto la volta gotica dell’ingresso: qui un altro servo dal passo furtivo, mi condusse silenziosamente attraverso un labirinto di tenebrosi corridoi, verso lo studio del suo padrone.
Non so perché questa breve e insieme interminabile passeggiata rinforzò le mie sensazioni precedenti. Mentre gli oggetti che mi circondavano, il legno intagliato dei soffitti, le fosche tappezzerie delle pareti, il nero d’ebano dei pavimenti, gli illusori trofei araldici che vibravano al mio passaggio, avrebbero dovuto, pensavo, essermi familiari, mi stupii che mi scatenassero emozioni che non conoscevo. Per una delle scale incontrai il medico di famiglia. La sua espressione era insieme perplessa e astuta. Si volse verso di me con aria imbarazzata e scivolò via di soppiatto. Finalmente il servo mi introdusse alla presenza del padrone.
La stanza in cui mi trovavo era immensa e i soffitti altissimi. Le finestre erano lunghe, strette e a sesto acuto e a una tale distanza dal sobrio pavimento di quercia da essere irraggiungibili dall’interno. La luce fioca e cremisi che riusciva a penetrare attraverso i pannelli intelaiati serviva appena a rendere visibili gli oggetti di maggior rilievo; lo sguardo si perdeva però a scrutare gli angoli più nascosti e il soffitto a volta.
Scure tappezzerie pendevano dalle pareti. L’arredo era eccessivo, trasandato, scomodo. Libri e strumenti musicali giacevano sparsi ovunque, senza vita. Mi rendevo conto di respirare un’aria carica di pena. Un’aria di irrimediabile cupezza che invadeva e imprigionava tutto.
Quando entrai Usher si alzò dal divano dove era disteso. Mi salutò con tale calore e vivacità che mi fece pensare subito all’esagerazione e allo sforzo dell’uomo di mondo ennuyé. Bastò però uno sguardo al suo volto perché mi accorgessi della sua totale sincerità. Sedemmo e per un po’ restò muto; lo fissai con un sentimento misto di pietà e timore.
Di sicuro nessun uomo poteva essere tanto terribilmente cambiato, e in così breve tempo, quanto Roderick Usher! Solo a fatica potevo accettare che quel languido uomo esangue fosse il mio compagno d’infanzia. È vero che il suo volto aveva sempre avuto qualcosa di singolare. Pallore cadaverico, occhi grandi, umidi e incomparabilmente luminosi; labbra pallide e serrate, dal disegno di sorprendente bellezza; la linea del naso, dal delicato profilo ebraico, insolitamente interrotta dalla larghezza delle narici; mento che, mancando di ogni prominenza, rivelava una qualche mancanza di energia morale. Capelli più delicati e sottili di una ragnatela: questi tratti, uniti a tempie eccessivamente ampie, gli conferivano in complesso una fisionomia non facilmente dimenticabile. Ma ora, l’esasperazione del carattere prevalente dei suoi lineamenti e della loro espressione abituale, lo avevano cambiato al punto che non mi rendevo conto di chi avessi davanti. Più di ogni altra cosa mi allarmavano il pallore mortale della pelle e lo sguardo lucido e quasi irreale. Anche i capelli serici erano cresciuti incolti, e poiché, nella loro trama sottile e disordinata, fluttuavano più che intorno al viso, non riuscivo neanche con uno sforzo a ricollegare l’attuale immagine arabesca a un’idea di semplice umanità.
Del suo comportamento mi colpì l’incoerenza, direi, la quasi inconsistenza, e mi accorsi rapidamente che derivava dalla sua fiacca lotta contro un’ansia abituale, contro l’eccessiva agitazione nervosa.
A tutto questo ero stato in qualche modo preparato, non soltanto dalla lettera, ma anche dal ricordo di alcuni suoi tratti giovanili e dalla conclusione cui mi avevano portato la sua conformazione fisica e il suo particolare temperamento. Il suo comportamento era, alternativamente, vivace e pigro. La sua voce passava rapidamente dalla tremula indecisione (quando l’energia animale sembrava completamente assente) a una sorta di energica concisione, che suonava brusca, grave, calma e sorda: quel modo di parlare gutturale, plumbeo, controllato e perfettamente modulato proprio dell’ubriacone incallito ο dell’incorreggibile mangiatore d’oppio, nei momenti di più intensa eccitazione.
Fu in tale modo che mi parlò dell’oggetto della mia visita, del suo intenso desiderio di vedermi e del conforto che si aspettava da me.
Cominciò poi a parlare della natura della sua malattia. Si trattava, secondo lui, di un male ereditario, una condanna familiare, e, per questo, riteneva che non vi fosse scampo, ma poi aggiungeva che era una semplice affezione nervosa, che si sarebbe risolta rapidamente. La malattia si manifestava in una serie di mostruose sensazioni.
Raccontate nei dettagli, alcune di queste, mi parvero interessanti e sconvolgenti, certamente anche per il modo con cui le raccontava. Soffriva di una morbosa ipersensibilità; sopportava soltanto i cibi più insapori; poteva indossare soltanto certi tessuti e non altri, il profumo di qualunque fiore gli era intollerabile, gli occhi non sopportavano neanche l’idea della luce; tutti i suoni, esclusi quelli degli strumenti a corda, lo riempivano di orrore.
Lo osservai e capii che era schiavo di un’anomala specie di terrore. «Morirò», disse, «devo morire in questa miserabile follia. Così, soltanto così, avrò pace. Ho paura del futuro, non in sé, ma per i suoi effetti su di me. Tremo al solo pensiero del più banale incidente, per quello che provocherebbe su questa mia insopportabile tensione mentale; non mi spaventa il pericolo, ma la sua inevitabile conseguenza, cioè il terrore. In questa condizione snervante e pietosa, sento profondamente che arriverà il momento in cui, prima ο poi, dovrò abbandonare vita e ragione insieme, nella lotta con questo fosco e misterioso fantasma: la PAURA.»
Dai suoi discorsi discontinui e dalle sue ambigue allusioni, mi resi conto di un altro aspetto del suo stato mentale. Era come incatenato da alcune superstizioni che riguardavano la casa, cui si sentiva di appartenere e dalla quale da tanti anni non usciva più, per una cieca sottomissione a forze strane; usò termini troppo oscuri perché possa accennarvi, un influsso originato, diceva, da alcune peculiarità della materia stessa e dalla forma della dimora familiare. E attraverso una lunga sofferenza, l’effetto physique di quei muri grigi, di quelle torri che si specchiavano nello stagno, aveva, infine, agito sulla morale della sua esistenza.
Ammetteva tuttavia, seppure con un po’ di riluttanza, che questa folle malinconia poteva anche avere origini meno oscure e più naturali.
La malattia della sorella, per esempio, la lunga e grave malattia di una sorella molto amata e da molti anni sua unica compagna e unica parente rimastagli. Parlava della prossima morte di lei, con una amarezza che non posso cancellare dalla mente. Mentre parlava, lady Madeline, questo era il nome di lei, passò lenta in fondo alla sala. Senza aver notato la mia presenza, scomparve. La guardai con l’animo diviso tra stupore e spavento, senza capire i miei sentimenti e seguii i suoi passi mentre se ne andava, preda di un senso di attonita oppressione. Mentre la porta si chiudeva dietro di lei, cercai istintivamente e con ansia il volto del fratello. Invano, si era nascosto la faccia tra le mani. Potevo vedere soltanto le lacrime che inumidivano le sue pallide e nervose dita.
Il male di lady Madeline aveva da molto tempo sconcertato e messo alla prova le capacità dei medici. Una permanente apatia, un consumarsi graduale della persona, attacchi frequenti anche se passeggeri di semicatalessi; questa l’insolita diagnosi. Finora aveva resistito fermamente contro il male, rifiutando di mettersi a letto, ma proprio la sera del mio arrivo, così mi riferì il fratello, nel corso della notte, in preda a un’agitazione indescrivibile, aveva dovuto cedere all’irresistibile potere maligno del male. Seppi così che la sua fugace apparizione poteva essere l’ultima, che avrei potuto non vedere più la signora, almeno non viva.
Per parecchi dei giorni successivi il suo nome non fu più pronunciato, né da Usher né da me. Durante questi giorni feci molti sforzi per alleviare la malinconia del mio amico. Dipingevamo, leggevamo ο ascoltavo soltanto, come perduto in un sogno, le sue scatenate improvvisazioni di canto e chitarra. Col crescere dell’intimità, potevo entrare nei recessi della sua anima, constatando con amarezza quanto fosse vano il tentativo di rallegrare la sua mente posseduta da una tenebrosità, congeniale come una forza positiva, e che lui riversava su tutta la materia fisica e morale, in una incessante proiezione depressiva.
Non potrò mai sopportare il ricordo di quelle ore solenni passate insieme al signore della Casa Usher. Non riuscirò in nessun modo a rendere l’idea del suo tipo di studi e interessi di cui mi rendeva complice e nei quali mi trascinava, facendomi da guida. Una tensione ideale esasperata e turbata copriva tutta la scena di luci brucianti. I lunghi e subitanei inni funebri che improvvisava risuoneranno per sempre nelle mie orecchie. Tra l’altro, mi è restata dolorosamente impressa nella mente quel suo strano, perverso arrangiamento della melodia sfrenata dell’ultimo valzer di Von Weber, ο quei suoi dipinti sui quali tornava continuamente a meditare, che si scomponevano, tocco dopo tocco, in una indeterminabile vaghezza che mi faceva tanto più rabbrividire quanto meno capivo perché. Di questi dipinti (le cui immagini sono ancora vivide nella mia mente) invano tenterei di trovare una sia pur piccola parte che possa essere espressa con semplici parole scritte. Con l’assoluta semplicità dei suoi disadorni disegni attirava e soggiogava l’attenzione. Se mai mortale ha dipinto un’idea, questi fu certamente Roderick Usher. Delle pure astrazioni che quell’ipocondriaco faceva uscire fuori dalla sua tela ti abbagliava l’intensità lancinante. Al confronto, le ardenti chimere di Fuseli sembrano ancora troppo concrete e impallidiscono.
Proverò a tradurla in parole, per quanto insufficienti, scegliendo un esempio fra i meno astratti del suo spirito visionario: un piccolo dipinto che raffigurava l’interno di una lunghissima galleria con una volta rettangolare dai muri bassi, bianchi e lisci, senza fregi. Alcuni particolari del disegno suggerivano l’idea che questa cavità si trovasse a grande profondità sotto la superficie terrestre.
Per tutta la sua estensione non si notavano vie d’uscita; né una fiaccola, né altra fonte di luce artificiale e, tuttavia, lo spazio era pieno di abbaglianti raggi che tutto illuminavano, di uno splendore ingiustificato e irrimediabile.
Ho già parlato della abnorme insofferenza del malato a ogni specie di musica, a eccezione di certi effetti degli strumenti a corda. Erano forse proprio questi limiti stravaganti che, in gran parte, accentuavano il carattere fantastico delle sue esecuzioni alla chitarra, ma la fervida facilità dei suoi impromptus restava in qualche modo inspiegabile. La loro eccezionalità stava proprio nelle note, come pure nelle parole delle sue fantasie selvagge. Poiché spesso si accompagnava con improvvisazioni verbali in rima, il risultato di questa totale padronanza mentale e capacità di concentrazione, cui ho già alluso in precedenza, era percepibile soltanto in questi particolari momenti di eccitazione artificiale.
Mi è stato facile ricordare le parole di una di queste sue rapsodie. Mentre me la proponeva ne fui particolarmente impressionato; forse perché nel suo occulto significato mistico credevo di notare per la prima volta una piena consapevolezza del tracollo della sua ragione. I versi che lui aveva intitolato «Il palazzo incantato» suonavano press’a poco così:
I.
Nella più verde delle nostre valli
Protetta da angeli buoni,
Un tempo un palazzo bello e nobile,
Un palazzo radioso, levava la testa
Nelle terre di re Pensiero -
Qui si ergeva!
Mai serafino allargò le sue ali
Su un edifìcio tanto bello.
II.
Bandiere gialle gloriose d’oro
Sul suo tetto sventolavano
(Tutto questo accadeva nel tempo antico
Da cui tanto tempo è trascorso).
E per l’aria soave nel gioco
In quelle dolci giornate
Sui bastioni chiari e piumati
Si spargeva un odore di ali.
III.
Chi attraversava la valle felice
Da due luminose finestre poteva vedere
Muoversi musicalmente gli spiriti
Al suono del liuto ritmato;
Un trono dove si vedeva assiso
(Porfìrogenito!)
Nella gloria della sua grandezza
Il Signore del reame felice.
IV.
E risplendente di perle e rubini
Era la porta del bel palazzo,
Da cui fluendo, fluendo, fluendo
E brillando di luce mai vista
Delle Eco la schiera più dolce
Non faceva che cantare
Con voci di arcana bellezza
La saggezza e il talento del Re.
V.
Ma diaboliche cose, vestite di lutti,
In agguato nel regno del Sire,
(Consentiamoci il pianto, poiché mai più,
Il domani per lui sorgerà desolato!)
Circondarono la sua casa. La gloria
Che splendeva e fioriva,
Non è che una storia passata
Di un antico tempo sepolto.
VI.
Chi percorra adesso la valle,
Dalle rosse finestre vedrà
Varie forme fantastiche in moto
Al suono di melodie dissonanti;
E, come un fiume veloce di spettri
Attraverso le pallide porte
Una orribile folla si accalca
E ride, ma non sorride più.
Ricordo perfettamente che le suggestioni di questa ballata ci condussero attraverso una sequenza di pensieri in cui si manifestava un’opinione di Usher che cito non tanto per la sua originalità (altri infatti hanno pensato la stessa cosa1), quanto per l’ostinazione con cui la difese.
L’opinione, nel suo assunto generale, accreditava la teoria della capacità del mondo vegetale di sentire. Ma nella sua disordinata mente, questa idea si era fatta ancora più audace allargandosi fino a includere il regno inorganico. Non mi bastano le parole per esprimere la dimensione, ο il sincero abbandono alla sua convinzione.
Questa fede assoluta, come ho già accennato, era connessa alle grigie pietre della casa dei suoi antenati. Egli immaginava che qui le condizioni di questa sensitività erano state poste in essere fin nel metodo di collocazione di queste pietre, nell’ordine con cui erano state disposte, nell’intrico di fungi che le ricoprivano ο in quegli alberi morti che circondavano la casa, ma soprattutto nella lunga indisturbata resistenza di questa sistemazione e del suo doppio, che si realizzava nel riflesso con cupe acque dello stagno. Il segno evidente, il segno di questa capacità di sentire lo si poteva vedere, disse (e a questo punto mi fece trasalire), nel graduale lento e tuttavia certo condensarsi di un’atmosfera propria delle acque e dei muri. Il risultato era riscontrabile in quella silenziosa e inesorabile influenza che aveva per secoli offuscato il destino della sua famiglia e fatto di lui, da quello che potevo constatare, quello che egli era.
Sono opinioni che non hanno bisogno di commento e io non le commenterò.
I nostri libri, quei libri che da anni contribuivano solidamente alla vita mentale del malato, erano, come è immaginabile, in stretto rapporto con questa sua dimensione visionaria. Meditavamo insieme su opere come Vertvert et Chartreuse di Gresset, Belfagor di Machiavelli, Cielo e inferno di Svedenborg, Viaggio sotterraneo di Nicholas Klimm di Holberg, Chiromanzia di Robert Flud ο quella di Jean d’Indaginé, ο di De La Chambre, Viaggio nell’azzurro di Tieck, Città del Sole di Campanella. Uno dei preferiti era il Directorium Inquisitorum del domenicano Eymeric de Gironne; e vi erano infine brani di Pomponius Mela sugli antichi satiri ed Egipani dell’Africa, sui quali Usher poteva sognare per ore. Il suo piacere maggiore consisteva però nell’attenta lettura di un volume rarissimo e curioso, un inquarto gotico, un manuale su una chiesa dimenticata, le Vigiliae mortuorum secundum Chorum ecclesiae maguntinae.
Non potevo fare a meno di meditare sul carattere selvaggiamente rituale di quest’opera, e sulla sua influenza su un ipocondriaco, quando una sera, dopo avermi bruscamente informato della morte di lady Madeline, mi dichiarò la sua intenzione di conservare il corpo per quattordici giorni (prima della sua sepoltura definitiva) in una delle molte cripte che si aprivano nel sotterraneo della casa. Sul motivo che fornì per questo modo di agire tanto singolare, non volli discutere.
Il fratello era stato spinto a questa decisione dall’insolito carattere della malattia della defunta e da alcune impazienti e indiscrete richieste avanzate dai medici e, infine, dal fatto che il cimitero di famiglia fosse molto distante e difficilmente accessibile. Non negherò che, tornatomi alla mente il volto sinistro della persona incontrata per le scale, il giorno del mio arrivo, non sentii l’esigenza di oppormi; anzi, mi parve una precauzione del tutto attendibile e innocua.
Lo aiutai personalmente, come Usher mi chiese, nei preparativi di quella temporanea sepoltura. Una volta deposto il corpo nella bara, lo portammo, noi due soli, al suo riposo. La cripta in cui lo collocammo (rimasta chiusa tanto a lungo che le nostre torce soffocate dall’aria opprimente non davano luce bastante per un’adeguata indagine), era piccola, umida e priva di aperture che consentissero l’ingresso della luce.
Si trovava a grande profondità, proprio sotto quella parte della casa in cui era situata la mia stanza da letto. In remota epoca feudale, stando alle apparenze, doveva essere stata adibita alla crudele funzione di carcere e, più di recente, si era trasformata in deposito di polveri da sparo ο altre sostanze combustibili. Una larga parte del pavimento,
fatti, e tutto l’interno di un lungo passaggio di accesso alla cripta erano sistematicamente coperti di rame; anche la porta di massiccio ferro era rivestita dello stesso metallo: a causa del suo immane peso, girando sui cardini, produceva un rumore aspro e stridente.
Deponemmo il nostro funebre carico su due tripodi collocati in questo luogo d’orrore e scostammo parzialmente il coperchio non ancora inchiodato.
Scrutai allora il volto della defunta. Per la prima volta constatai con sorpresa la straordinaria somiglianza tra fratello e sorella; Usher, indovinando il mio pensiero, balbettò alcune frasi smozzicate da cui capii che erano gemelli e che tra di loro era sempre esistita una affinità di natura difficilmente comprensibile. I nostri sguardi non restarono a lungo rivolti alla morta: non potevamo continuare a guardarla senza provare un dolore ansioso. La malattia che l’aveva portata alla tomba nel fiore di una giovinezza appena matura aveva lasciato, come tutte le malattie a carattere prevalentemente catalettico, la beffa di un rossore appena percettibile sul volto e sul petto e quel misterioso sorriso sulle labbra che è così terribile nella morte. Riabbassammo il coperchio e lo bloccammo inchiodandolo e, dopo aver chiuso a chiave la pesante porta di ferro, risalimmo faticosamente fino agli appartamenti superiori della casa, certamente non meno opprimenti.
Dopo alcuni giorni di aspro dolore, un evidente cambiamento si produsse nel disordine mentale del mio amico. Il suo solito comportamento scomparve, le sue occupazioni ordinarie venivano trascurate ο dimenticate.
Vagava di stanza in stanza con passi affrettati e discontinui. Il pallore del suo viso aveva assunto sfumature ancora più spettrali mentre la luminosità del suo sguardo si era completamente spenta. La sua voce aveva perso la consistenza aspra di una volta; si era fatta tremula, come spezzata dal terrore. C’erano momenti in cui ero convinto che la sua mente agitata fosse combattuta da un divorante segreto e che egli lottasse con se stesso per trovare il coraggio di svelarlo.
Altre volte però ero costretto a tornare a credere che tutto fosse dovuto alle divagazioni inesplicabili della sua follia; lo sorprendevo a fissare nel vuoto per lunghe ore come se fosse in ascolto di un suono immaginario. Non può stupire che questo suo stato mi terrorizzasse e anzi invadesse anche me. Lentamente e inesorabilmente, sentivo di essere posseduto dalle selvagge influenze delle sue superstizioni, strane e coinvolgenti.
Fu proprio la sera del settimo ο ottavo giorno successivo alla deposizione di lady Madeline nella cripta, mentre stavo ritirandomi per la notte, che provai appieno la prepotenza di queste sensazioni. Il sonno tardava a venire e le ore trascorrevano. Cercavo di razionalizzare il nervosismo che si era impadronito di me. Mi costringevo a credere che il mio stato d’animo fosse determinato dalla influenza deprimente del cupo mobilio della stanza, dei tendaggi pesanti e sgualciti che ondeggiavano come torturati dal fiato impetuoso di un ancora lontano temporale.
I miei sforzi furono inutili. Presi a tremare in modo irrefrenabile, a poco a poco il mio cuore fu posseduto da un incubo, da un terrore che sembrava senza causa. Tentai di liberarmi respirando profondamente, mi sollevai sui cuscini cercando di penetrare l’oscurità, con le orecchie tese e allarmate (forse come spinto da una premonizione), percepii bassi suoni indefiniti che giungevano a lunghi intervalli, nelle pause dell’uragano che ormai imperversava, da non so dove. In preda a un orrore profondo, inspiegabile e tuttavia insopportabile, mi vestii precipitosamente (ormai sapevo che per quella notte non avrei più dormito), cercando con tutte le mie forze di sottrarmi a quello stato pietoso in cui ero caduto. Mi misi ad andare su e giù per la stanza a grandi passi.
Passarono alcuni brevi minuti quando mi parve di cogliere il rumore di un passo leggero sulla scala vicina. Lo riconobbi, era quello di Usher.
Un attimo dopo bussò leggermente alla mia porta ed entrò nella stanza portando con sé una lampada. Come sempre era cadaverico, sfinito ma soprattutto nei suoi occhi brillava una luce di pazza euforia e i suoi gesti rivelavano accessi di isteria, appena contenuta. Il suo comportamento mi faceva paura ma mi sembrava che tutto fosse più sopportabile della solitudine in cui mi ero sentito soffocare tanto a lungo e lo accolsi con sollievo.
«Non l’hai visto?», mi chiese bruscamente dopo avermi fissato per qualche istante in totale silenzio. «Così, dunque, tu non l’hai visto. Allora resta e vedrai.»
Detto questo, schermò con la mano la lampada e si diresse alla finestra che spalancò alla tempesta. La furia impetuosa dell’uragano ci sollevò quasi da terra. La notte tempestosa era paurosamente bella, una terribile bellezza, singolare e tragica. Ci trovavamo evidentemente nell’occhio del ciclone, il vento subiva frequenti e violenti mutamenti di direzione e le nubi spesse e basse, a ridosso delle torri della casa, non ci impedivano di cogliere la straordinaria velocità con cui si precipitavano dai più svariati punti per scontrarsi e convergere fra loro, senza mai distanziarsi. La loro densità, come ho detto, non ci impediva di vederne le forme, anche se la luna non era visibile neanche di sfuggita, né si vedevano le stelle, né alcun lampo illuminava la scena.
Tuttavia le superfici inferiori di quella enorme massa turbolenta erano di fuoco, come tutti gli oggetti che ci circondavano, illuminati da una luce innaturale. Una esalazione gassosa, una luce vaga che avvolgeva tutta la casa come un sudario.
«Non devi fermarti a guardare, non guardare!…», dissi a Usher rabbrividendo e tentando di allontanarlo con gentile violenza dalla finestra. «Queste apparenze che ti sconvolgono non sono altro che fenomeni elettrici non rari, ο che hanno origine dalle intense esalazioni dello stagno. È meglio chiudere la finestra. Fa freddo, la tua salute può risentirne. Ho qui uno dei tuoi romanzi preferiti; io leggerò per te, tu ascolterai… e questa terribile notte passerà.»
L’antico volume che avevo preso in mano era il Mad Trist di sir Launcelot Canning; per scherzo, ma un malinconico scherzo, lo avevo definito il preferito da Usher; in realtà ben poco nel suo andamento prolisso e privo di immaginazione poteva interessare l’animo nobile e raffinato del mio amico. Ma era l’unico libro a portata di mano e avevo la speranza che l’agitazione che lo torturava potesse placarsi (nella storia della follia simili anomalie sono frequenti) proprio con la lettura di vicende eccezionalmente pazze.
A giudicare dall’attenzione con cui ascoltava ο fìngeva di ascoltare, avrei potuto congratularmi con me stesso per questa buona iniziativa.
Ero in procinto di leggere quel famoso passo in cui l’eroe del Trist, Ethelred, dopo aver tentato invano di essere ammesso pacificamente nell’abitazione dell’eremita, decide di entrare usando la forza. Ecco le parole del racconto: «Ethelred, impavido per natura e reso più incosciente dal vino trangugiato, non volle più umiliarsi nel chiedere ascolto all’eremita, uomo ostinato e maligno, ma alla prima pioggia che sentì cadere e paventando lo scatenarsi dell’uragano, senza altro indugio sollevò la mazza ferrata e con furiosi colpi divelse le assi della porta. Spezzò e schiantò tutto mentre il rumore del legno secco che si spaccava risvegliava con la sua eco tutta la foresta».
Su questa battuta mi fermai trasalendo; mi era parso, ma decisi subito che la fantasia mi stava giocando brutti tiri, mi era parso di udire, proveniente da un lato molto remoto della casa, un rumore, l’eco, soffocata e sorda, di quel rumore del legno secco spezzato che sir Launcelot aveva così dettagliatamente descritto. Sicuramente si trattava di una coincidenza che si era proposta alla mia attenzione, visto che lo strepito cigolante degli infissi e il fragore del temporale erano tanto invadenti che quel rumore in sé non poteva colpirmi ο turbarmi. Ripresi a leggere: «Ma il gagliardo Ethelred, oltrepassata la soglia, dovette sorprendersi e molto adirarsi a non trovare dinanzi a sé l’eremita; al suo posto un drago d’orrido aspetto, coperto di squame e dalla lingua infuocata, messo a guardia di un palazzo d’oro e d’argento. Dal muro pendeva uno scudo bronzeo che portava la scritta:
Varcata la soglia sarai vincitore,
uccisa la bestia, lo scudo al migliore.
Allora Ethelred, sollevata la mazza, la calò sulla testa del drago frantumandola. Il drago esalando l’ultimo pestilenziale respiro cacciò un urlo tanto forte e aspro che Ethelred dovette tapparsi le orecchie per non sopportarne l’orrendo rumore mai prima d’allora udito».
Mi fermai di nuovo bruscamente, in preda allo stupore, non vi erano dubbi, questa volta avevo udito – difficile soltanto capire da dove provenisse – l’urlo lontano, ma forte e aspro, come nel racconto, lo stesso urlo innaturale del drago descritto dal narratore. Colpito da questa seconda straordinaria coincidenza, oppresso da mille sensazioni contrastanti in cui dominavano la sorpresa e il terrore, tentai di conservare la calma per evitare al mio amico un’ennesima sovreccitazione del suo fragile sistema nervoso. Non ero certo che si fosse accorto anche lui dei rumori, sicuramente però nel suo comportamento da alcuni minuti era visibile una strana alterazione.
Dalla posizione iniziale, seduto di fronte a me, aveva lentamente e progressivamente girato la seggiola in modo da guardare la porta; per questo potevo vederne soltanto una parte del viso e notare il tremito delle labbra, come se stesse mormorando parole inintelligibili. La testa era reclinata sul petto e dallo scorcio del suo profilo capii che non dormiva, anzi i suoi occhi erano spalancati. Anche il movimento del corpo era in contrasto con l’ipotesi che dormisse, dondolava innanzi e indietro in modo costante e uniforme.
Ripresi a leggere: «A questo punto l’eroe salvatosi dalla furia del drago, ricordò lo scudo di bronzo e l’incantesimo dal quale era stato liberato, calpestò la carogna che gli ostacolava il passo e si mosse arditamente sul pavimento d’argento del castello, verso il luogo in cui era appeso lo scudo, che non attese il suo arrivo e cadde ai suoi piedi con un rimbombo greve e terribile».
Appena pronunciate queste parole, nello stesso momento, come se uno scudo di bronzo fosse veramente caduto pesantemente su un pavimento d’argento, udii una vibrazione metallica, cava e sonora, che sembrava smorzata.
Sfinito e coi nervi a pezzi, balzai in piedi precipitandomi verso la seggiola in cui era seduto Usher. Aveva gli occhi fissi davanti a sé e il suo volto sembrava pietrificato; appena poggiai la mano sulla spalla tutto il suo corpo cominciò a tremare violentemente; un torvo sorriso ne deformava la bocca, vedevo che parlava in modo sommesso e frettoloso; balbettava parole inarticolate senza avvedersi di me.
Quando mi chinai su di lui finalmente riuscii a cogliere l’orrendo senso delle sue parole.
«Non l’ho sentito? Certo che l’ho sentito… sempre…per lunghi minuti, per giorni lo sentivo…e non ho osato…oh! pietà di me!..miserabile disgraziato… nient e altro sono…non ho avuto coraggio…non ho osato…l’abbiamo sepolta viva! Non ti avevo detto dell’acutezza dei miei sensi? Ti dico ora che ho sentito i suoi primi deboli movimenti nella cavità della cripta, dentro quella orrenda bara. Li ho sentiti tanti e tanti giorni fa, eppure non osavo parlare. E adesso, questa notte Ethelred ah! ah! L’abbattimento della porta dell’eremita, l’urlo del drago, il clangore dello scudo!!! Di’ piuttosto l’infrangersi della sua bara, il suono stridente dei cardini di ferro della sua prigione e la sua vana lotta contro l’arcata di rame della cripta!! Dove fuggirò? Lei sarà qui, tra poco! Non sta forse già affrettandosi per rimproverarmi la mia precipitazione? Non si sentono già i suoi passi per le scale? Non sto ascoltando per caso l’orribile battito del suo cuore affannato? Pazzo!».
Balzò in piedi preso da una tremenda furia e urlò, come se questo estremo sforzo esaltasse la sua anima, queste parole: «Pazzo, ti dico, ORA ELLA È IN PIEDI FUORI DI QUESTA PORTA».
Sembrò quasi che la sovrumana energia della sua voce avesse la forza di un incantesimo, le pesanti ante dell’antica porta, che parlando indicava, aprirono lentamente le loro fauci nere.
Fu certamente per effetto di una forte raffica di vento, ma fuori della porta stava in piedi, avvolta nel sudario, la figura amata di lady Madeline Usher.
I suoi bianchi abiti erano macchiati di sangue e i segni di un’aspra lotta erano visibili su tutto il suo corpo emaciato. Per un attimo rimase tremante, barcollante sulla soglia, poi con un lungo e terribile gemito sommesso, cadde pesantemente sul corpo del fratello, e nei supremi e violentissimi, ultimi, spasimi della agonia lo trascinò sul pavimento, cadavere e vittima dei terrori che lui stesso aveva anticipato.
Da quella stanza e da quella casa fuggii terrorizzato.
L’uragano infuriava ancora con forza, mentre attraversavo l’antico sentiero. Improvvisamente rifulse una stranissima luce. Mi volsi per capire da dove poteva venire, se dietro di me c’erano soltanto l’immensa casa e le sue ombre. Erano i raggi della luna piena che stava tramontando, rossa come sangue, che d’improvviso splendevano vividamente attraverso quella crepa nel muro della casa di cui ho già parlato, che attraversava a zig zag tutta la facciata, dal tetto alla base. Mentre la guardavo, la crepa si allargò rapidamente, l’aria turbinava impazzita, credetti di cogliere l’intera orbita del satellite, il mio cervello vacillò mentre vedevo le possenti mura spalancarsi. Sentii un lungo tumultuante rumore simile al frastuono di mille acque e il profondo stagno nero ai miei piedi si chiuse, cupo e silenzioso, su quello che restava della casa Usher.
1 Watson, Dr. Percival, Spallanzani e, in particolare, il vescovo di Landaff, Saggi chimici, vol. V (Ν.d.A.).



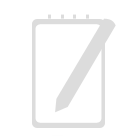
Recent Comments